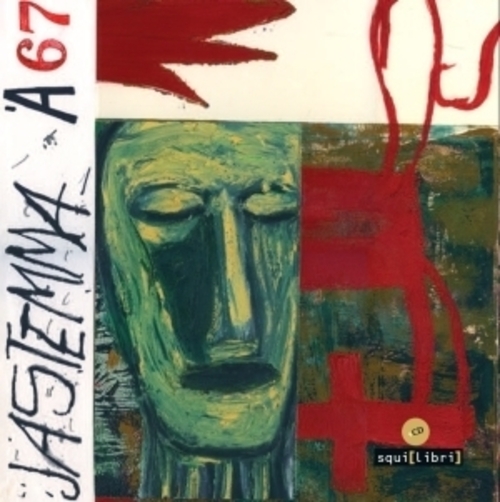di Alfredo Franchini
“C’era una volta un bell’algoritmo/ che si muoveva di qua e di là/ gironzolava sul web col ritmo/ di chi sa già quello che farà/ andava matto per Cipro e Malta/ dove si fanno le società/ i trust di diritto turco/ o se ti piace una bella Spa”.
La nuova economia dominata dalla finanza entra nel mondo della canzone con una band atipica formata da tre giornalisti del Sole 24 Ore: Mauro Meazza, Stefano Elli e Marco Lo Conte, abituati di giorno a raccontare i fatti economici sul quotidiano della Confindustria e di sera a salire sul palco facendosi chiamare Ciappter Ileven.
Nella terra dei cachi la canzone satirica non è una novità. I precedenti sono tanti, da Ettore Petrolini che metteva alla berlina i personaggi dell’epoca a Rodolfo De Angelis che novant’anni fa poneva una domanda di stretta attualità anche oggi: “Ma cos’è questa crisi”? Poi negli anni Sessanta la satira sociale in musica avrebbe toccato livelli altissimi con Renato Carosone, basti pensare a Tu vuò fa l’americano, e con Fred Buscaglione, l’uomo dal whisky facile che cantava di bulli e pupe. E così via negli anni. Edoardo Bennato riempiva gli stadi alla fine dei Settanta, (fu il primo a cantare a San Siro), ironizzando sul Papa, “affacciati, affacciati, benedici, guardaci, tanto son quasi duemila anni che stai a guardare” e persino su se stesso, “tu sei saggio, tu porti la verità, ah ah ah, tu sei un cantautore!
Si può ridere usando l’arma del vituperium e dell’ironia così come ha fatto in modo davvero feroce Fabrizio De André raccontando la storia di un servitore dello Stato, una guardia carceraria, costretto a rivolgersi all’antistato, don Raffaè, per ottenere qualche piccolo favore. Sorrideva Luigi Tenco prendendo di mira il consumismo, (La ballata della moda), negli anni del boom economico. Chi poi della satira ha fatto un uso abituale è Guccini, dalle prime ballate e dalla descrizione della Genesi attraverso un’opera buffa, sino al Testamento di un pagliaccio, brano inserito nell’ultimo disco di inediti, peraltro cupi. Andare, camminare, lavorare è il ritratto spietato che Piero Ciampi ha fatto degli anni del boom italico: “Il meridione rugge, il Nord non ha salite… il passato nel cassetto chiuso a chiave/ il futuro al Totocalcio per sperare” … Nel repertorio dei maggiori cantautori c’è sempre una pagina satirica a rimarcare il tempo in cui prevale l’ora del dilettante, come canta Max Manfredi e quella “civiltà fatta di menzogne/ di eserciti, di carogne/ preistoria degli equilibristi, decalogo degli analisti” cantata da Cristiano De André in Lady Barcollando.
Insomma, la canzone è spesso andata al cuore della società facendoci riflettere. Potremmo citare Gaber che praticò la satira nel Teatro canzone, (Io se fossi Dio/ non sarei mica stato a risparmiare/ avrei fatto un uomo migliore), e nemmeno Jannacci che, secondo Francesco Baccini – anch’egli maestro di satira con canzoni che avevano nomi e cognomi come Andreotti– è stato campione di ironia.
A chi si rifanno i musicisti-giornalisti Ciappter Ileven? Senza fare paragoni impossibili, le loro radici affondano nel cabaret milanese dei Gufi e dell’indimenticabile Nanni Svampa che, tra l’altro, aveva una laurea in Economia alla Bocconi.
L’algoritmo regola il lavoro e decide le nostre vite. Ci sono state persone che hanno perso il posto e altre che hanno perso i soldi investiti. Come un angelo custode, abbiamo tutti un algoritmo personale che sa cosa ci piace mangiare, che conosce i nostri amici e anzi li sceglie lui. Come se fosse un articolo di giornale i Ciappter Ileven cantano: si costruisce una piattaforma che ti permette di investire online; poi devi convincere il pensionato a investire dove tu vuoi, tanto lui non ha confidenza con l’elettronica e con il pc.
E allora prima si offre al malcapitato una consulenza e una cifra per iniziare, gli si apparecchia un bel conto in saldo e lui comincia a investire ma coi consigli sbagliati... quel conto inizia la discesa verso il rosso.
I tre giornalisti del Sole sono degli istrioni dalla rima facile, non perfetta ma efficace: “Attilio tu mi mandi in visibilio/ poi per un piccolo “sbalio”/ vuoi prendermi il mobilio”, con riferimento a Befera, l’ex capo dell’Agenzia delle Entrate. La musica segue gli stilemi del folk rock e tra i bersagli c’è ancora la Fornero definita “santa patrona degli esodati”. Ironia e comicità nel repertorio che diventa satira quando si tratta di descrivere lo stato dell’economia con brani come Il consulente o, come detto, l’Algoritmo.
Il gruppo degli economisti-musicisti tornerà sul palco tra novembre e dicembre di quest’anno per una serie di concerti di beneficienza con lo scopo di divertire ma anche di far riflettere sulle distorsioni del capitalismo perché si sa non sono solo canzonette.
Articolo pubblicato su Extra Music Magazine, 1 agosto 2023