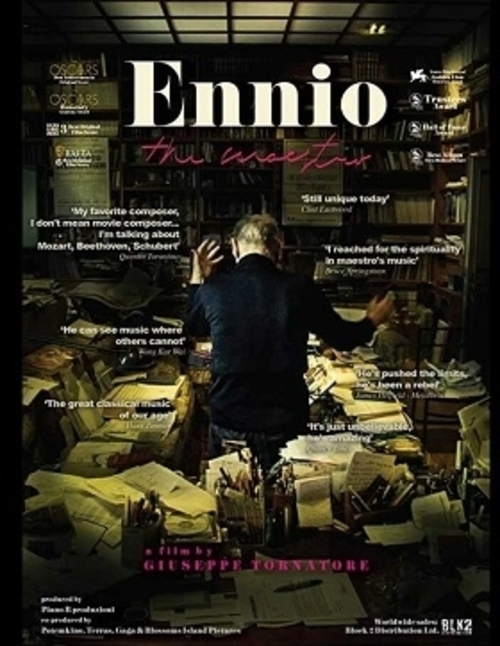di Alfredo Franchini
Anche la primissima Viola della Scala si incazza per la cultura dimenticata in Italia. E sotto il tiro di Danilo Rossi, violinista e violista di fama internazionale, finiscono la politica e i mass media. La goccia che ha colmato il vaso della sopportazione è stata la vittoria ignorata da tutti di un ragazzo di vent’anni, Giuseppe Gibboni, in un concorso violinistico internazionale che l’Italia non vinceva da ventiquattro anni. Una notizia passata sotto silenzio. Così Rossi ha preso carta e penna e ha scritto una lettera indirizzata al presidente della Repubblica per denunciare una situazione grottesca: l’estata trascorsa ha portato medaglie e coppe nello sport e i vincitori sono stati portati sugli allori e ricevuti a Palazzo Chigi e al Quirinale. Al contrario, i successi di due italiani nel concorso pianistico Chopin di Varsavia e la vittoria di Gibboni al Paganini di Genova sono stati ignorati. Extra Music Magazine ha parlato con Danilo Rossi della questione culturale in Italia.
_ Iniziamo dalla domanda più banale: perché ha scritto quella lettera a Mattarella?
“Non voglio abbassare il livello della discussione mettendo in discussione lo sport che, tra l’altro, amo e seguo con entusiasmo. E non sto nemmeno tra coloro che accusano i calciatori di essere pagati troppo. Volevo solo dire che che certi onori in questo Paese devono essere riconosciuti a chi ha un valore internazionale, a chi si impegna. So cosa vuol dire vincere un concorso internazionale, quanto studio c’è dietro”.
_ Anche perché lei vinse il suo primo concorso violinistico a sedici anni.
“È vero e poi a vent’anni ero alla Scala dove – ci tengo a dirlo – si entra solo con un concorso. Insomma, voglio dire che non si possono ignorare i talenti che abbiamo in casa”.
_ Che cosa è successo dopo la vittoria di Gibboni? Mi risulta che l’Ansa abbia dato la notizia.
“È questo è ancora più grave. Significa che la notizia è passata ma i mezzi di informazione l’hanno ignorata. Solo tre giorni dopo è stata ripresa in breve da un quotidiano e sono trascorsi altri nove giorni, (e soprattutto la denuncia di Danilo Rossi, N.d.R.), perché fosse trasmessa nel Tg1 delle 20. Non sarebbe male se adesso gli organi di informazione prendessero atto di aver preso una bella cantonata. È chiaro che la stampa ritiene che la notizia del violinista eccellente non faccia audience e non capisce che se avessero il coraggio di parlarne ogni giorno avvicinerebbero una persona in più”.
_ Lei spara su politica e sui giornali ma non pensa che anche la società sia accondiscendente? Sulle grandi questioni noto un silenzio degli intellettuali. Come nel Falstaff, per restare in tema di musica, tutto declina.
“Direi di no. La cultura non è trascurata se la mia lettera ha avuto un boom sulla rete. La gente ha detto basta, chi scrive ha ragione. Mi sarebbe piaciuto se quelle persone avessero mandato una lettera ai giornali, come si faceva una volta, ma i tempi sono cambiati, oggi si condivide sui social, e il dibattito è diventato virale con oltre centomila visualizzazioni”.
_ Un allarme sulla questione culturale in Italia è stato lanciato negli ultimi mesi da due musicisti: uno è lei e, in precedenza, lo aveva fatto Riccardo Muti con un’intervista al Corriere della Sera. Chi sono i musicisti oggi?
“Nell’immaginario collettivo noi siamo privilegiati e lo siamo come tutti coloro che fanno un lavoro che amano. Ma siamo anche persone che per raggiungere certi livelli si fanno un mazzo per tutta la vita. Questo non è riconosciuto ma i sacrifici devono essere valorizzati e lo dico per tutte le professioni”.
_ Da qui la rabbia che traspare nella sua lettera?
“Sono un romagnolo verace, dico quello che penso. L’Italia impegna lo 0,27 del Pil per la cultura contro il due per cento del Pil della Francia che investe dieci volte rispetto a noi. Se si duplicassero le risorse nel nostro Paese verrebbero riaperti i teatri e ci sarebbero più orchestre e più occasioni per i giovani”.
_ È nota la scarsa alfabetizzazione musicale, tra l’altro in Italia si vendono molto meno strumenti rispetto agli altri Paesi.
“Sì, dimenticando che siamo quelli che hanno inventato la musica, che nel Settecento hanno insegnato a tutto il mondo il melodramma. Per questo ogni tanto c’è un musicista come me che si incazza”.
_ Lei insegna al Conservatorio e quindi ha il polso della situazione dei giovani.
“Ce ne sono tanti bravi e lasciatemi dire che non è facile essere giovani oggi proprio perché non sono valorizzati. Prendiamo anche le polemiche sui Maneskin: si dovrebbe solo essere contenti che quattro ragazzi italiani vadano in America. Erano anni che questo non accadeva. I Maneskin sbancano e vanno ad aprire il concerto dei Rolling Stones. Sono grandi risultati, tutto fa parlare della cultura in Italia, io mi entusiasmo”.
_ I suoi studi classici, il fatto di essere la prima Viola della Scala, non le hanno impedito di avvicinarsi ad altri generi come ad esempio al jazz. Qual è la sua idea di musica?
“Sono solo molto curioso e non finisco mai di cercare cose diverse da quelle che faccio ogni giorno. Ho avuto la fortuna di incontrare musicisti straordinari che mi hanno coinvolto dal pop al jazz. Non sono un compositore ma un esecutore, però credo che sia chiaro a tutti che non esistono più gli steccati, che è bene non tirare su nuovi muri, sia quelli veri e sia quelli culturali. Le dico una cosa: io vengo dal liscio, a quattordici anni passavo l’estate nelle balere della Romagna a suonare con le orchestre da ballo. Non me ne vergogno, è stata una grande palestra”.
_ Che cosa risponde a chi disse che con la cultura non si mangia?
“Che dovrebbe vergognarsi. Ritorno a parlare della Francia. Ci sono i musicisti fortunati, quelli come me, che lavorano tutti i giorni e ci sono quelli che non hanno la stessa possibilità. Bene, lo Stato francese garantisce una continuità salariale a quanti non hanno la possibilità di lavorare quotidianamente. Durante il lockdown in molti hanno scoperto che la musica è cibo per l’anima, ma si sono dimenticati di quei musicisti per i quali la musica è cibo, cioè è la possibilità di pagare le bollette”.
_ Nicola Piovani ha detto che la musica è pericolosa, nel senso che ha un potere trascendentale. Per lei cos’è?
“La musica è cultura, fantasia, potere di aggregazione. Ma dietro al talento dei musicisti c’è tanto lavoro e mi incazzo se non viene riconosciuto”.
Articolo pubblicato su Extra Music Magazine, 3 novembre 2021